
Non m'importa se Dio muore
George Orwell
Sulle questioni poetiche George Orwell aveva le idee chiare. Prediligeva Thomas Hardy e Rupert Brooke; al T.S. Eliot dei "Quattro quartetti" – un vate troppo pomposo – anteponeva quello delle rime giovanili; detestava, con gioviale cinismo, Wystan H. Auden (“è un Kipling senza fegato”) e Stephen Spender. D’altronde, in uno scritto del 1946, "Why I Write", Orwell confessava di avere esordito come poeta: “Scrissi la prima poesia all’età di quattro o cinque anni, dettandola a mia madre”; era un plagio di William Blake. Da ragazzo, lo affascinarono le ballate di Robin Hood e il "Paradiso perduto" di Milton. Tutti i grandi scrittori del Novecento, in effetti – pensiamo a James Joyce, a William Faulkner, a Ernest Hemingway –, sono poeti messi all’angolo, lirici mancati per un attimo. Orwell praticò la poesia con talento anomalo, sporadicamente, per tutta la vita: il suo modello è un Jonathan Swift vissuto nell’era atomica. Spesso i versi hanno un’arguzia dolente, da aspide (“Sono il verme che mai divenne / Farfalla, l’eunuco senza harem / […] Non ero nato per un’età come questa”). Nell’oggi profetizzato da Orwell, dove la scrittura esiste per annacquare gli spiriti, per celebrare – magari con provocazioni ad hoc – lo status quo, la poesia è la sola arma per abbattere il Grande Fratello.
Disponibile in 5 giorni lavorativi Ordina libro
Dettagli Libro
- Titolo: Non m'importa se Dio muore
- Autore: George Orwell
- Curatore:
- Traduttore:
- Illustratore:
- Editore: De Piante Editore
- Collana: I solidi
- Data di Pubblicazione: 2023
- Pagine: 170
- Formato: Brossura
- ISBN: 9791280362483
- Bambini e ragazzi - Libri illustrati
Libri che ti potrebbero interessare

Fattoria degli animali
George Orwell

Nineteen eighty four. Con CD-ROM
George Orwell
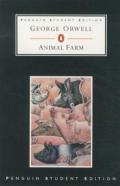
Animal Farm
George Orwell

Animal Farm: The dystopian classic reima...
George Orwell

Keep the Aspidistra Flying
George Orwell

Clergyman's Daughter
George Orwell

Burmese Days
George Orwell

Coming Up for Air
George Orwell
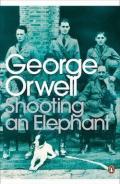
Shooting an Elephant and Other Essays
George Orwell

Nineteen Eighty-Four: The Annotated Edit...
George Orwell

Nineteen Eighty-Four
George Orwell

1984, Level 4, Penguin Readers (Penguin ...
George Orwell






