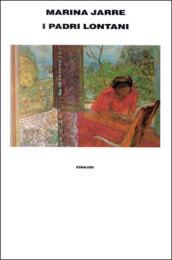
I padri lontani
Marina Jarre
"Io non piango e non mi stupisco, io racconto". Marina Jarre potrebbe assumere questa rigogliosa dichiarazione come motto del libro con cui torna alla narrativa dopo un silenzio di qualche anno. Si tratta, in apparenza, di un'autobiografia, che si snoda tra la Lettonia degli anni '20 e '30 (incrocio di culture e genti diverse, dove la Jarre è nata), il piccolo mondo ordinato e dignitoso delle valli valdesi e la Torino dei nostri giorni. Vi campeggiano figure e ambienti familiari: il padre, che viene da una famiglia di ebrei russi, con il suo aspetto di principe arabo, notturno ed elusivo, sempre impegnato in affari strampalati; la madre, volitiva insegnante di lingue, fedele alle altezze del proprio stile e alle regole che impone a sé e agli altri; la sorella, i nonni, e poi la nuova famiglia che l'autrice si costruisce.Il tono, tuttavia, non è quello del vagheggiamento del tempo perduto, in chiave lirica e nostalgica, di tanta letteratura di memoria, ma quello asciutto e essenziale di chi cerca un dialogo con se stesso, le persone della sua vita, i lettori. Il tema che corre per tutto il libro è il confronto tra le generazioni, l'opposizione radicale tra il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, poetico e fantasioso, ma anche sottilmente logico e rigoroso, e quello distratto e imprescrutabile degli adulti, tanto spesso assenti. Lontano e minaccciso appare anche il padre per eccellenza, il dio degli antenati valdesi, con le sue collere e le sue punizioni, con la sua richiesta di portare pesi sovrumani e di soffrire in silenzio. Eppure quel rapporo così difficile non si interrompe mai del tutto, segue ragioni e percorsi suoi, tra fedeltà di fondo e desideri di emanciapzione, e sembra che solo il tempo e il ricordo riescano a farlo maturare.Il libro è soprattutto un "romanzo di formazione", dove campeggia un intrepido personaggio femminile che cerca tenacemente di restare se stesso e di realizzarsi, tra timore e fervore, rabbia e pietà, orgoglio e tenerezza.
Prodotto fuori catalogo
Dettagli Libro
- Titolo: I padri lontani
- Autore: Marina Jarre
- Curatore:
- Traduttore:
- Illustratore:
- Editore: Einaudi
- Collana:
- Data di Pubblicazione: 1997
- Pagine:
- Formato:
- ISBN: 9788806594213
- Bambini e ragazzi - Narrativa
Libri che ti potrebbero interessare

Ritorno in Lettonia
Marina Jarre

I padri lontani
Marina Jarre

Negli occhi di una ragazza
Marina Jarre

I padri lontani
Marina Jarre

Negli occhi di una ragazza
Marina Jarre

Ritorno in Lettonia
Marina Jarre

In Russia con Rainer
Lou Andreas-Salomé, M. Jarre, Lou Andreas Salomé, Marina Jarre

Ti ho aspettato, Simone
Marina Jarre

Neve in Val d'Angrogna. Cronache di un r...
Marina Jarre

Fuochi
Renzo Sicco, Marina Jarre

Cattolici si, ma nuovi
Marina Jarre







